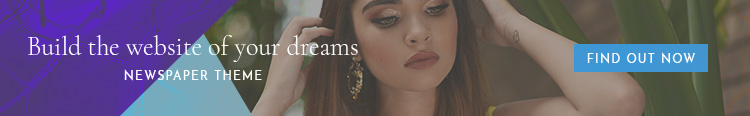Gabriele Niola, firma di tante recensioni cinematografiche pubblicate su Wired e Bad Taste, è docente del master di critica giornalistica dell’Accademia d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha pubblicato con UTET un libro intervista a Gabriele Muccino intitolato La vita addosso e adesso ha scritto un pamphlet sul cinema italiano.

Vi proponiamo un estratto dal suo saggio per Bietti Fotogrammi Odio il cinema italiano – 7 ragioni per sostenerlo con successo in ogni conversazione – disponibile sul sito dell’editore in formato Epub e su Amazon per Kindle
Questo è un corollario dell’odio. Ve lo dico subito.
Tutto il cinema vive di schemi, strutture e generi codificati, e non c’è niente di male, alcuni dei film migliori di sempre aderiscono in pieno a uno o più cliché (Casablanca, 1942) oppure ci si appoggiano solidamente per innovarli (Per un pugno di dollari, 1964).
Il problema viene quando modelli e strutture smettono di essere gabbie che stimolano la creatività e aiutano la produzione, per diventare gabbie che impediscono l’innovazione. Il western è nato, cresciuto e tramontato, il noir si è trasformato mille volte e anche il genere dei film di supereroi sta cambiando e a un certo punto morirà.
Il cinema italiano invece è aggrappato con una violenza inaudita a certe formule e, quanto di peggio, ogni tentativo di allontanarsene genera allarmi e piagnistei.
Abbiamo già scritto di come le produzioni italiane campino sulle commedie in viaggio verso Sud, oppure sui drammi da periferia, o ancora sulle commedie borghesi, incastrando gli attori in ruoli sempre uguali. Si tratta di generi e sottogeneri nati o portati alla ribalta da elementi esogeni: la commedia in viaggio verso una parte del Paese più selvaggia viene dall’estero, dal francese Giù al Nord (2008), e anche il cinema criminale napoletano viene da fuori, cioè dalla televisione, da Gomorra. La serie.
Come se non bastasse, poi, questi schemi sono pochi. La fabbrica del cinema italiano ha un numero limitatissimo di catene di produzione, piega tutti i suoi registi e sceneggiatori verso le consuetudini, marginalizzando come un outsider chi si muove ad altre latitudini. Per fare un esempio, a Susanna Nicchiarelli – che con Nico, 1988 (2017) e poi Miss Marx (2020) ha dimostrato di poter e voler pensare qualcosa di diverso – è stato chiesto di esordire con una commedia anni Sessanta, Cosmonauta (2009), e poi con un film tratto da un libro di Walter Veltroni, La scoperta dell’alba (2012). Matteo Rovere, che poi si sarebbe dedicato a film di corse (Veloce come il vento, 2016) e d’azione (Il primo re, 2019) è dovuto prima passare dai drammatici e convenzionali Un gioco da ragazze (2008) e Gli sfiorati (2011) per poter entrare nell’industria e, con pazienza, farsi strada verso altri lidi.
I migliori esordi che ricordiamo – Alì ha gli occhi azzurri (2012)di Claudio Giovannesi (che poi avrebbe diretto Fiore nel 2016 e La paranza dei bambini nel 2019), Cuori puri (2017)di Roberto De Paolis, La terra dell’abbastanza (2018) dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo (tornati con Favolacce nel 2020) – sono tutti film ottimi ma ingabbiatissimi, che cercano in ogni modo di interpretare con efficacia schemi, storie, ambientazioni e idee che troviamo anche altrove invece di battere territori effettivamente nuovi. Provare a fare qualcosa di inedito è un privilegio che va guadagnato, da che dovrebbe essere il contrario: è con qualcosa di nuovo che ci si propone per la prima volta, perché dovrebbe essere più desiderabile.
Invece la macchina dei film italiani è così rodata, i suoi meccanismi così oliati, i solchi tracciati così in profondità, da ricondurre ogni deviazione sulla strada “maestra”. Il risultato è che la fabbrica del cinema italiano non sa produrre altro da ciò che ha già prodotto, e riprodotto, e riprodotto.